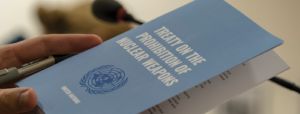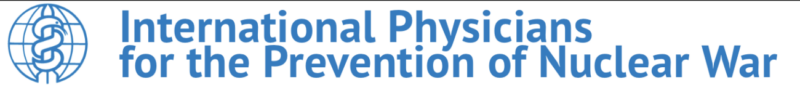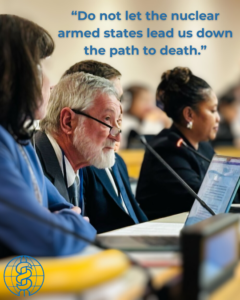Dal professor Alessandro Pascolini (Università di Padova) un approfondimento, alla luce del Trattato NPT, dopo le recenti operazioni belliche degli Stati Uniti contro i siti nucleari nella Repubblica Islamica dell’Iran.
La notte del 21 giugno scorso con l’operazione Midnight Hammer gli Stati Uniti hanno colpito i siti del programma nucleare iraniano a Natanz, Isfahan e Fordo; sette bombardieri strategici Stealth B-2 Spirit hanno rilasciato circa 75 bombe di precisione guidate, inclusi 14 penetratori GBU-57 Massive Ordnance da 30000 libbre (13,6 t), in grado di colpire anche strutture sotterranee, mai usa; in precedenza; l’attacco fu completato da 30 missili cruise Tomahawk lanciati da un so’omarino nucleare della classe Ohio dal golfo di Oman. Una forza imprecisata di caccia americani di quarta e quinta generazione hanno colpito i sistemi di difesa antiaerea iraniani a protezione dei B-2.
L’operazione è avvenuta di sorpresa, in assenza di una dichiarazione di guerra (una specie di “operazione militare speciale”) e non è stata preceduta da forme di ultimatum, ma mentre erano in corso negoziati fra Iran e gli USA appunto sul programma nucleare di Teheran.
Impianti di arricchimento e NPT
Poiché l’unico e preciso obiettivo di Midnight Hammer è stato la distruzione totale del programma iraniano di arricchimento dell’uranio (a completamento degli attacchi di Israele dei giorni precedenti) vale la pena considerare l’operazione alla luce del Trattato di non proliferazione (NPT), di cui sia l’Iran che gli USA sono parte.
Gli articoli III e IV del NPT riguardano specificatamente lo sviluppo pacifico dell’energia nucleare e il suo controllo. L’art. III impegna ogni stato militarmente non nucleare (NNWS) parte del trattato a sottoporre i propri impianti e i materiali fissili al controllo e a speciali salvaguardie da parte dell’Agenzia atomica internazionale (IAEA) per impedire la diversione dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari. Il terzo comma attenua il rigore dei controlli, precisandone la necessaria compatibilità col diritto di tutte le parti alla tecnologia nucleare e che devono evitare di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle parti, o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche.
L’articolo IV recita precisamente:
- Nessuna disposizione del presente Trattato deve essere considerata come pregiudizievole per il diritto inalienabile delle Parti di promuovere la ricerca, la produzione e l’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, senza discriminazione e conformemente alle disposizioni degli articoli I e II qui innanzi.
- Tutte le Parti si impegnano a facilitare lo scambio più intenso possibile di attrezzature, materiali e informazioni scientifiche e tecnologiche, per l’uso pacifico dell’energia nucleare, e hanno diritto a partecipare a tale scambio. Le Parti, in condizioni di farlo, debbono anche collaborare contribuendo, sia individualmente sia assieme ad altri Stati od organizzazioni internazionali, all’ulteriore sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare soprattutto nei territori degli Stati non nucleari, che siano Parti del Trattato, tenendo debitamente conto delle necessità delle regioni in via di sviluppo.
Sull’uso pacifico dell’energia nucleare si sono contrapposte le posizioni di coloro che difendono i diritti di accesso alla tecnologia in sé e di coloro che leggono nell’NPT un forte impegno a condividere i benefici nucleari ma al contempo la necessità di trattare le richieste di accesso a specifiche tecnologie come questioni politiche da stabilire caso per caso, tenendo conto di varie condizioni quali la capacità delle salvaguardie di fornire un avviso tempestivo di usi impropri.
Le tecnologie in questione riguardano essenzialmente l’arricchimento dell’uranio e la separazione del plutonio, che a molti appaiono difficilmente verificabili con la necessaria precisione, ingiustificate dal punto di vista economico e che troppo facilmente possono venir convertite a scopi militari. Gli impianti a centrifugazione richiedono la massima attenzione per prevenire la proliferazione nucleare, dato che uno stesso impianto può produrre in un anno, a partire da 150 t di uranio naturale, o 20 t di LEU al 4% (il consumo annuo di un reattore da 1 GWe) o 550 kg di HEU al 93%, sufficiente per 26 bombe; nel primo caso la centrifugazione procede in una cascata a 10 stadi, nel secondo a 32 stadi.
Impianti di arricchimento sono stati comunque accettati come “diritto inalienabile” anche dei NNWS e sottoposti alle salvaguardie della IAEA; ne esistono in Argentina (capacità di 20k SWU/anno), Brasile (capacità di 60k SWU/anno), Germania (capacità di 3600k SWU/anno), Olanda (capacità di 5100k SWU/anno) e Iran (capacità di 43k SWU/anno); anche il Giappone sta realizzando un impianto. Lo SWU (separative work unit) misura la capacità di arricchimento; la grande capacità degli impianti europei Urenco è dovuta all’alta capacità delle singole centrifughe (fino a 300 SWU/anno) mentre le più avanzate centrifughe IR-6 iraniane non superano i 10 SWU/anno.
Rispetto dello spirito e della lettera del NPT
Una volta accettata la possibilità per gli NNWS di creare impianti di arricchimento, purché sottoposti alle salvaguardie della IAEA, tutte le parti del NPT sono impegnate a garantire anche all’Iran il diritto inalienabile al proprio programma di arricchimento; appare quindi evidente che la missione americana finalizzata alla distruzione degli impianti nucleari iraniani viola lo spirito del NPT , in particolare essendo stati appunto gli USA a formulare (con l’Unione Sovietica) lo stesso testo del trattato, di cui costituiscono uno stato depositario.
Si tratta in realtà della seconda volta in cui gli USA distruggono gli impianti nucleari di un paese non militarmente nucleare parte del NPT. Nell’ambito dell’operazione “Package Q” il 19 gennaio 1991 forze aeree americane attaccarono pesantemente il centro irakeno di Al Tuwaitha distruggendo i due reattori di ricerca operativi IRT-5000 e Tammuz 2 oltre a laboratori di fisica nucleare e radiochimica, strutture per la fabbricazione di combustibile, la stazione per il trattamento delle scorie e depositi di materiali nucleari.
Secondo il generale Norman Schwartzkopf, a seguito dell’azione la capacità del paese di sviluppare armi nucleari aveva subito “una battuta d’arresto considerevole, se non una battuta d’arresto totale”, mentre in realtà le strutture di Al Tuwaitha servivano solo per ricerche civili, coperte dalle salvaguardie della IAEA.
A quel tempo, il bombardamento di Al Tuwaitha non provocò alcuna protesta o azione diplomatica significativa. La guerra del Golfo avveniva per un mandato del Consiglio di sicurezza dell’ONU a “utilizzare ogni possibile mezzo per costringere l’Iraq a ritirarsi dal Kuwait e per ristabilire la pace e la sicurezza internazionali nell’area”. La generale ostilità internazionale all’Iraq e il diffuso consenso alla distruzione del suo programma nucleare “militare” resero accettabile l’operazione e non vi fu alcuna segnalazione al Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Solo in seguito giuristi internazionali cominciarono a esaminare se l’operazione non fosse andata oltre i limiti del mandato dell’ONU e un riflesso degli eventi si trova nella formulazione delle decisioni prese nella Conferenza di revisione ed estensione del NPT del 1995, vincolanti appunto all’estensione indefinita del trattato; si decise appunto che:
20. Gli attacchi o le minacce di attacco a impianti nucleari destinati a scopi pacifici mettono a repentaglio la sicurezza nucleare e sollevano serie preoccupazioni riguardo all’applicazione del diritto internazionale sull’uso della forza in questi casi, che potrebbero giustificare un’azione appropriata in conformità alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.
Anche nell’ultima Conferenza di Revisione che ha prodotto un documento approvato all’unanimità (2010) viene ribadita la condanna per attacchi a impianti nucleari civili e proposta una precisa “raccomandazione per azioni successive”:
Azione 64: la Conferenza invita tutti gli Stati a rispettare la decisione adottata per consenso dalla Conferenza generale dell’AIEA il 18 settembre 2009 sul divieto di attacco armato o di minaccia di attacco contro impianti nucleari, in funzione o in costruzione.
Poiché sia le “decisioni” della conferenza di estensione del 1995 che le “azioni” raccomandate nella conferenza di revisione del 2010 sono tuttora valide e vincolanti, dobbiamo concludere che con l’operazione Midnight Hammer gli Stati Uniti hanno violato sia lo spirito che la lettera del Trattato di non proliferazione.
Inoltre, il ricorso all’operazione militare dimostra che il governo americano non ha alcuna fiducia nei meccanismi previsti dal NPT per la gestione di eventuali infrazioni del trattato e nella stessa IAEA.
Questa mia lettura degli eventi nella sua ingenuità può venir dimostrata errata da esperti di diritto internazionale, e il comportamento americano considerato consistente con il NPT.
L’evento è comunque un viatico ominoso per la prossima Conferenza di revisione del trattato prevista fra meno di 10 mesi, aggiungendosi a una crescente serie di incidenti e difficoltà del regime di non proliferazione: i fallimenti delle Conferenze del 2015 e del 2022, l’incapacità di raggiungere un documento condiviso nei lavori dei tre comitati preparatori della Conferenza del 2026, i problemi posti dall’occupazione russa della centrale ucraina di Zaporizhzhia; nuove propulsioni nucleari di significativi settori dell’opinione pubblica e politica di vari paesi; la recente (25 giugno) approvazione da parte del Parlamento iraniano di una legge che sospende la cooperazione con l’AIEA, condizionando il futuro accesso degli ispettori all’approvazione del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, un provvedimento che potrebbe preludere a un ritiro dell’Iran dal trattato.
Va infine osservato che nel febbraio del 2026 viene a cessare il trattato New START, unico trattato di limitazione delle armi nucleari strategiche di USA e Russia, in assenza di negoziati per un qualche controllo degli armamenti atomici.
Con queste prospettive, diviene difficile anche sperare che il Trattato di non proliferazione, unico a disciplinare globalmente l’energia nucleare e a imporre il disarmo degli ordigni atomici, possa avere la durata imperitura decisa nella Conferenza del 1995.
Alessandro Pascolini – Università di Padova
3 luglio 2025